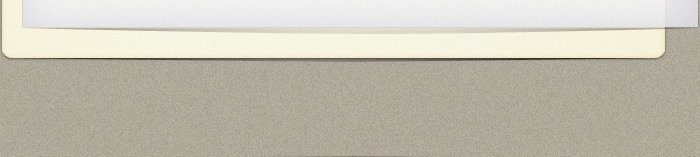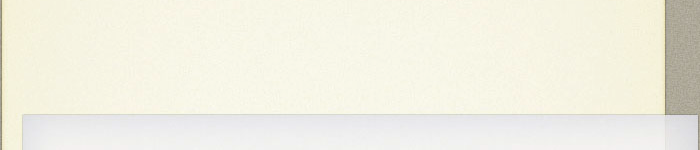




leggere il testo di
leggere il testo di PierLuigi Berto
leggere la testimonianza di Giuliano de Marsanich
leggere il testo di Marco Nocca
leggere il testo di Gabriele Simongini
leggere il testo di
leggere il testo di Catherine Velly
leggere il testo di Marco Di Capua
leggere il testo di
leggere il testo di
in catalogo

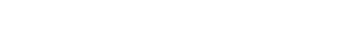
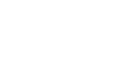
All’Istituto nazionale per la Grafica
Una mostra a Roma riporta l'attenzione su Jean Pierre Velly, artista francese trapiantato in Italia, che ha raccontato la vita come "vuoto a perdere". A cui comunque rendere omaggio senza distinguere tra le mille forme della Natura
«La vita è una cosa meravigliosa che finisce terribilmente male». La pensava così Jean Pierre Velly (1943-1990). E senza saperlo probabilmente riassumeva in una frase la sua stessa biografia. Un inizio folgorante: borsa di studio a villa Medici negli anni d’oro della direzione Balthus, premio che lo incorona maestro dell’incisione, decisione di restare a vivere vicino a Roma, a Trevignano, laboratorio a Formello, mostre di successo che gli conquistano l’attenzione di grandi mecenati collezionisti come Barilla e Olivetti, la simpatia e la stima di critici e intellettuali del calibro di Moravia, Sciascia, Soavi. Poi improvvisa la morte: è in gita col figlio sul lago di Bracciano, le onde si alzano, la barca si ribalta, e lui, un bretone che come molti suoi compaesani ha l’acqua come orizzonte ma non sa nuotare, annaspa e sprofonda giù, annegando. Il suo corpo non verrà mai ripescato, alimentando sospetti e leggende che trovano esca nell’aura luciferina delle sue opere.
L’esistenza come una beffa, un insensato scorrere verso la fine: è su questo transito e soprattutto sull’orizzonte cupo della scomparsa verso cui ci conduce che Jean Pierre Velly costruisce il suo universo d’autore con un rigore, una sincerità e una forza di fascinazione che resistono al tempo perché trascinano chi conosce e ricorda le sue opere e chi le riscopre per la prima volta in un tempo che non ha età. Lo conferma la mostra che a venticinque anni dalla morte lo riporta alla ribalta nelle sale di palazzo Poli, recuperando dall’ingiusto oblio dell’attenzione e del mercato il meglio della sua produzione dispersa in varie collezioni private e restituendogli una corona da primattore che il suo inatteso uscire di scena gli aveva negato.
Un maestro rigoroso, crudele e fuori moda. Come la tecnica dell’incisione in cui ha primeggiato. Come il suo campo d’azione: cogliere e raccontare la vita partendo dal baratro in cui deve inesorabilmente precipitare. Una sfida però attualissima, questo imporre lo spettacolo della morte a una società come la nostra che, sposando l’istante, ha voltato le spalle alla morte e ai suoi riti, rinnega il suo continuo manifestarsi come un’incidente, uno scandalo.
Ma per coglierne la portata della sfida bisogna adottare il punto di vista di Velly. Quel suo sguardo che parte da lontano, una memoria antica confinata nella penombra, dove i confini tra bene e male, commedia e tragedia, sbiadiscono. Quello sguardo che ci guarda remoto e severo nell’inquietante serie di autoritratti che i curatori hanno appeso nella sala d’ingresso. Velly si disegna e si dipinge come un gentiluomo d’altri tempi, i capelli lunghi e increspati, smorfie e rughe di dubbio scolpite su una faccia indecifrabile, pietrificata da una vecchiaia che avanza. E che l’autore accentua. La carne che si fa teschio. Così si vede e vuol farsi vedere. Un artista che naviga verso il proprio naufragio.
Un romantico, forse. Sicuramente un’anima profondamente intrisa da quella malinconia che domina l’immaginario dei pittori nordici. La malinconia, che il suo maestro preferito, il tedesco Durer, ha immortalato in una icona che giustamente i curatori hanno inserito come bussola dell’intera mostra, impaginando le opere di Velly secondo un copione suggerito da quella celebre allegoria: un percorso battezzato dalle tre fasi del processo degli antichi alchimisti, Nigredo, Albedo e Rubredo.
Di alchimia Velly, confermano le testimonianze in catalogo di quelli che l’hanno conosciuto, si è sicuramente interessato. Ma è una chiave di lettura e rivisitazione a nostro avviso sbagliata, deviante. Perché quella scansione, quel tragitto mirato e graduale dal disordine all’ordine non trova posto nella sua produzione, che non raggiunge mai la sublimazione del processo di trasformazione della materia, per approdare alla perfezione distaccata dell’oro.
La fantasia di Velly ristagna sempre nella contemplazione della crudeltà, del dolore, della decomposizione. Un teatro dell’assurdo in bianco e nero (la tavolozza sacra delle incisioni), che abbraccia quasi senza distinzioni il destino dell’uomo e della natura. Ecco uno dei capolavori degli anni Sessanta: La strage degli innocenti (nella foto). Il massacro biblico restituito da un groviglio, un brulichio di corpi – oltre tremila, un miracolo di tecnica e disegno – che si addensa a coprire valli e colline, trasforma l’orrore in paesaggio, l’organico e in inorganico. Ecco la suggestiva serie di allegorie barocche degli esordi: enigmatici corpi femminili avvolti da macerie e rovine, la bellezza che si prolunga nell’entropia di una vita vegetale incontrollabile. Ecco le immagini di una dei cicli di incisioni sul leit motiv delle discariche e della spazzatura, che hanno decretato il successo di Velly: profetiche distese di scarti, accumulati gli uni sugli altri, con una vertiginosa attenzione ai dettagli, a raccontare le deriva dell’abbondanza, degli sprechi, delle contaminazioni che segnano l’inesorabile declino della ottusa società dei consumi e dell’opulenza. Sono gli stessi anni – nota in un’illuminante saggio in catalogo Gabriele Simongini – in cui Antonioni chiude il suo film Zabriskie Point, epopea di una fuga impossibile che sigilla nel dramma la ribellione dei figli dei fiori, con la sequenza di un esplosione e lo spettacolo di una pioggia di detriti che solcano il cielo di inutili e grottesche scorie di benessere. Lo stessa desolante denuncia che abita l’Apocalisse di Velly.
La vita come vuoto a perdere. A cui comunque rendere omaggio. Senza distinguere tra le mille forme della Natura. Rigettando la supremazia che l’uomo cerca di imporre, disprezzando e non riconoscendo diritti alla creature che sente diverse da se, sui cui ribalta le proprie paure. È la scala di valori ed orrori che Velly, ecologista ante litteram, ci sbatte in faccia in un ciclo d’incisioni e disegni che a mio avviso sono il culmine della sua carriera creativa e della fama di artista maledetto che lo circonda. Bestiario perduto :un campionario di vite dimenticate e immolate senza pietà. Blatte, tipi, pipistrelli, raffigurati come mostri da esposizione. Nelle sue opere grafiche il pittore bretone ne resuscita con grande realismo la forma da alieni di distanza e ribrezzo e nello stesso momento li uccide, inchiodandoli alla croce della loro diversità, riproponendo gli spilloni degli entomologi che li fermano al foglio come tracce di un delitto appena compiuto, che ancora getta sangue.
Unità di misura è ancora il colpo di falce della morte, la condanna capitale alla corruzione che ci grava addosso. No, Velly non insegue la tregua della trasformazione in oro degli alchimisti. Il suo regno è sempre l’Albedo, il momento d’incubazione della materia che si decompone E resta tale anche quando l’autore si apre alla liberazione del colore. Ecco la serie davvero singolare degli acquerelli, che presenterà in mostra alla fine degli anni Ottanta con una memorabile presentazione di Alberto Moravia. Nature morte. Quadri di fiori ed erbe che mandano in circolo melodie, inedite per Velly, di azzurri, rossi, gialli. Ma quel che ritrae è un mesto canto del cigno. Quelli che mette in posa sono fiori di campo, non fiori d’esposizione , una vita brevissima appena li strappi che trascolora subito nei toni rugginosi dell’appassimento. La morte che rivendica l’insensatezza terribile di storie spezzate. E la pittura che tenta ossessivamente di inseguire, catturare, separare l’attimo, il tempo del trapasso. L’unica via di fuga che Velly offre a chi guarda questi fogli e queste tele è il perdersi nella luce che punta verso l’alto. E chissà dove porta.
La mostra che terrà cartellone fino al 15 maggio è il risultato di una inedita collaborazione tra l’Istituto nazionale per la Grafica che la ospita e l’Accademia di Belle arti: due dei curatori, Pier Luigi Berto e Marco Nocca sono docenti dell’Accademia e hanno impegnato i propri allievi a studiare la grafica di Velly e a restaurarne le lastre originali. La terza, Ginevra Mariani, dirige la Calcoteca.