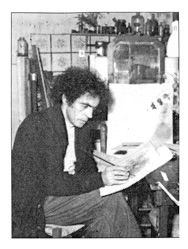I.
La campagna a nord di Roma è un luogo tra i più selvaggi d’Italia. Per visitarlo, bisogna lasciare le strade asfaltate e inoltrarsi tra boschi, sentieri, fontanili, pascoli abitati da buoi e cavalli. Un mondo dimenticato dall’occhio cittadino, che talvolta lo incontra nei vecchi dipinti di paesaggio o, più spesso nelle illustrazioni della pubblicità che accosta splendide visioni naturali, falsificate dai ritocchi, ai prodotti in commercio. Anche in viaggio, l’occhio è sequestrato dall’attenzione alla guida, e gli unici angoli di natura individuabili per un attimo sono quelli riprodotti sugli affissi.
Per inoltrarsi fuori strada il mezzo migliore è il cavallo. Qualsiasi andatura imponi alla bestia - passo, trotto, galoppo - sei in armonia con ciò che vedi, sul ritmo dello sguardo riposante o per il gusto concitato della corsa in amicizia con il vento che lustra i colori del cielo e della terra. Sei abbastanza in alto per non lasciarti invischiare dal sentimento; sei così impegnato con gli istinti della cavalcatura, tanto più forte di te, che ti pervade naturalmente il senso di un’antica signoria; puoi liberamente muoverti dovunque sia attirata la tua curiosità. E il respiro si apre, in accordo con il respiro delle cose.
Amo queste lunghe passeggiate che svelano immagini nascoste, un mulino in rovina accanto a un ponte ridotto all’osso sulla cascata di un torrente, un tratto semicoperto dai rovi di una strada romana dimenticata, un monastero cadente in cima a una rupe con pallidi residui di affreschi, una selva così buia e intricata la cui memoria credevi si conservasse soltanto nelle leggende. Un pomeriggio d’inverno, rientrando, fui colto da un temporale e arrivai fradicio alla scuderia. Lasciato il cavallo, mi fermai nel paese più vicino, Formello, per prendere una bevanda calda. Mentre sorbivo il cioccolato, qualcuno mi chiamò; mi voltai e vidi Jean-Pierre Velly. Ero contento di incontrarlo dopo molti anni. Velly era giunto a Formello lungo un itinerario diverso dal mio, venendo da lontano. Ora le nostre strade si incrociavano in questo paese per metà rustico e per metà rovinato dalla vicinanza con la capitale.
Bretone, Jean Pierre vinse a Parigi il Prix de Rome con una straordinaria incisione al bulino, La chiave dei sogni, che posseggo. In un paesaggio chimerico, reso con perfetta minuzia grafica, il nudo di una giovane donna in attesa d’un bimbo domina la scena con la sua triste bellezza.
Il premio valeva un soggiorno a Villa Medici e lì conobbi Jean Pierre, lì acquistai La chiave dei sogni. Allora quel francese allampanato, dai capelli ispidi, dallo sguardo intenso, era molto giovane, ma nella sua passione si percepiva il destino dell’artista privilegiato. Ho seguito la sua ascesa, comprando qualcosa da lui, e ricevendo dei doni, finché il successo, favorito anche da un intelligente gallerista, ha portato i prezzi così in alto da sottrarre le sue opere ai miei desideri.
Mentre scrivo, ho davanti agli occhi il suo foglio migliore tra quelli che posseggo, un disegno a punta d’argento - la tecnica di Pisanello. Nel bianco lievita la testa di una fanciulla dalla capigliatura massiccia, l’espressione severa, nemmeno un accenno di sorriso, lo sguardo fermo, quasi con una sfumatura di spavento, come vedesse per un istante quel che del futuro è ignoto. Ha lineamenti regolari, forse un po’ gonfi, ma non è graziosa: nel suo animo e nello stile dell’artista agisce una forza più importante del gusto di sedurre con la piacevolezza.
Velly è un maestro del tratto inciso, disegnato, o acquerellato. Da qualche anno ha cominciato a dipingere a olio, e il suo mondo si è fatto più cupo, illuminato a stento da stupefacenti allusioni alla bellezza perduta. Velly riporta alla luce idee antiche e strumenti di lavoro quasi dimenticati, la punta d’argento, il bulino che richiede una perizia da cesellatore, senza l’aiuto dell’acido che nell’acquaforte corrode il segno. Però le sue immagini non sono un ricalco del passato, anche se il passato si tramanda nelle visioni del presente. In mezzo a una foresta che sembra disegnata da Salvator Rosa, spuntano masse di rifiuti da cui emergono rottami di automobili. In un paesaggio che sembra concepito da Monsù Desiderio nascono forme meccaniche per dolce metamorfosi dalle pietre e dalle piante. I volti hanno una staticità ipnotica, spettralmente evanescenti e ossessivi; guardandoli da vicino si scorge che l’effetto sfumato è composto dal suo contrario, da un pulviscolo di segni nitidi, forse tracciati con l’aiuto di una lente. La forza dell’arte di Velly scaturisce da una fatica illimitata e austera. Anche i fiori, che sono la più festosa epifania della natura, e che Velly ama ritrarre, non hanno niente della sontuosità esplosiva fissata per sempre nei capolavori di Brueghel o di Van Gogh. Velly sceglie le sue corolle tra le più modeste per renderle nei colori e nelle movenze di un imminente appassimento, però con un’attenzione al particolare così acuta che dalle forme si sprigiona, insieme con la malinconia per quelle che sembrano delle reliquie, la potenza di una struggente rivelazione.
II.
Alla fine del periodo di pensionato all’Accademia di Francia, questo artista di formazione nordica era talmente legato all’Italia che decise di rimanervi; destino condiviso con tanti pittori francesi, fiamminghi, olandesi, tedeschi, i quali vennero per un viaggio di studio e non ripartirono, finendo per italianizzarsi. Però la città non è la pace e il verde di Villa Medici. Guardatesi intorno, Velly scelse di trasferirsi a Formello, la cui campagna verso la valle del Sorbo rammenta i paesaggi dipinti dagli artisti che lo precedettero nel viaggio al Sud. Al bordo del paese sopravvivono anche le vestigia di una «villa di delizie» eretta dai Chigi, con sotterranei dall’enigmatica funzione, lasciata decadere abbastanza presto dopo la fastosa esecuzione.
Tuttavia Formello non è così attraente come promettono il suo cielo e la sua campagna. Fuori le mura, il solito ciarpame di cemento; dentro, oltre alla chiesa e a un palazzo di qualche pregio ma dalle pietre incredibilmente corrose, si vedono strade anguste, case basse con piccole finestre; il sapore è autentico, mescolato però con un senso di clausura. Ma al pittore bretone questo luogo piace, vi si è sistemato da parecchi anni e non da segni di insofferenza.
Non lo vidi molto diverso da come lo ricordavo. Si stava concedendo una pausa davanti a una birra nel brutto caffè dentro la cinta medioevale, la mente ancora occupata dalle operazioni che l’arte imponeva alla sua immaginazione. Durante una cena, a Roma, mi disse indicandomi la bottiglia di vino: «Per te questa è una cosa comune; tu versi il vino, lo assapori, e la bottiglia è quasi insignificante. Per me è un problema, debbo studiare la direzione della luce, i colori della tovaglia e della stanza. Mi impedisce di distrarmi perché non è mai la stessa bottiglia, mai la stessa luce. Succede con il pane, con i piatti, con tutto». Non era pedante, confessava un legame. Io pensai che il compito dello scrittore è meno gravoso; una certa dose di passività, di profondo riposo, è indispensabile per predisporre la mente ad accogliere la parola.
Quella sera a Formello, bevuta la birra, mi invitò: «Vieni nel mio studio, ti mostro quello che sto preparando». Benché fossi zuppo, benché fino a qualche istante prima desiderassi di arrivare al più presto a casa, lo seguii attraverso le strade del borgo. Dopo pochi passi svoltammo in un vicolo, salimmo una breve scala di pietra, entrammo in uno stanzone che sembrava piuttosto un sotterraneo, dove, per l’umidità, era quasi più freddo che fuori. Quello studio così poco confortevole somigliava a un’officina alchemica. Gusci di lumache, ramaglie avvizzite, crani levigati di uccelli e di bovini, pupazzi disarticolati come creature sul punto di essere richiamate alla vita, scaffali ingombri di oggetti scombinati, in attesa che l’occhio dell’artista li estraesse dal letargo. Un torchio, un bancone sul quale erano sparsi gli strumenti per l’incisione del metallo e l’intaglio del legno, lastre di rame ossidate, odore di polvere e di acido.
Su un cavalletto stava prendendo forma un autoritratto a olio che signoreggiava sul disordine della stanza. La confusione e la tetraggine dell’ambiente assumevano all’improvviso un senso imperioso, come risucchiate negli occhi di quel personaggio ancora in parte evanescente, che sembrava Velly eppure si estraniava dal soggetto per un’accentuata durezza.
«È bello» dissi, «ha la forza di un autoritratto di Dürer. Però ti sei invecchiato».
Jean Pierre scrollò le spalle per la futilità della mia osservazione.
«Non so, non è questo. Ho paura di andare avanti. Troppa fatica. Se ritraggo un’altra persona è come se dipingessi un paesaggio, un mazzo di fiori, un albero; anche le cose hanno un’interiorità che devi capire, per cui i problemi non cambiano. Ma se ti metti di fronte alla tua anima le difficoltà si raddoppiano, devi guardare e lasciarti guardare nello stesso momento. È estenuante, forse per questo sembro più vecchio».
«Però sei riuscito a rendere qualcosa che si impone. Puoi lasciarlo così».
«Ma no, lo sai che ho la lealtà dell’artigiano. Debbo completare e rifinire tutto, non mi accontento dell’impressione. D’altronde è l’unica cosa che so fare. Sai, io ti invidio. Leggo i tuoi libri, mi soffermo tra le righe per capire il segreto della scrittura. Qualcuno pensa che l’autore si limiti a scrivere storie. Come le scrive, il giro delle frasi, questo è il segreto. Io non ci arrivo. So dipingere, non so raccontare. Ho provato, ma ho smesso subito, è un altro mestiere».
«A qualcosa è servito. Ora leggi meglio. A me è successo con la musica, la capisco di più da quando con i miei figli ho maneggiato il flauto dolce, uno strumento semplice, ma quante difficoltà! Adesso mi sembra un miracolo la compattezza di un’orchestra».
Non ebbi il coraggio di confidargli che da giovane avevo provato a dipingere. Poi gli chiesi: «Che cosa volevi scrivere?»
«Ho una bella storia, l’ho pensata parecchie volte, mi dispiace che rimanga nella mia mente».
«Raccontamela».
«Vuoi? Non è lunga, soltanto un’idea. Un bambino gioca alle biglie con gli amici. Quando crede di eseguire un buon colpo, rimane mortificato perché sbaglia. Cerca di esercitarsi da solo, ma raramente il lancio è buono, finché immagina che la sua inabilità dipenda da un difetto delle biglie: non sono ben lisce e quindi a contatto con il terreno distorcono le sue intenzioni. Pensa di fabbricare almeno una biglia perfetta. Questo progetto cresce insieme con lui, lo possiede al punto di spingerlo a lasciare il suo paese e a ritirarsi su una montagna la cui cima ha una forma tondeggiante. Colpo su colpo stacca il picco, lo lavora instancabilmente giorno dopo giorno, anno dopo anno; lo arrotonda con cura, non è mai contento. Parenti e amici hanno smesso i tentativi di distoglierlo da quell’impresa assurda. Non ha occhi ne orecchi per loro. Di rado compare in paese per qualche provvista, la sua casa è una capanna costruita sulla montagna. Finalmente riesce a ottenere la misura perfetta; ha tolto tanta di quella pietra che adesso la sfera, pervenuta alla rotondità ideale, è piccola come una biglia. Intanto sono trascorsi parecchi anni e giunge l’ora della fine per questo solitario scultore di una sola opera. Molto tempo dopo, un bambino accompagnato dal padre va in gita sulla montagna decapitata. Si fermano in una capanna cadente, colma di detriti. Il bambino vede una biglia straordinariamente liscia; la prende, e nota che alcuni frammenti di pietra aderiscono alla piccola sfera incastrandosi fra loro. Da quel momento è posseduto da un’idea che, crescendo, diventa lo scopo della sua vita. Proseguirà l’opera di restauro cercando pazientemente i pezzi giusti dentro la capanna, poi fuori, salendo fino alla cima della montagna mozzata. A volte trascorrono mesi prima che egli scovi il frammento successivo, e prenderà parecchie direzioni sbagliate prima di scoprire che l’itinerario dei pezzi mancanti conduce alla cima. Mentre la ricostruzione procede, l’opera assume a tratti forme fantastiche, un drago, un uccello deforme, una belva con una strana corona sulla testa. Benché inconsuete, queste effigi sembra che ubbidiscano a un progetto, per cui il restauratore pensa di aver finito il suo lavoro e si mette a contemplare il risultato. Però un impulso del cuore gli accende un sospetto di incompletezza e di disarmonia. Ricomincia a cercare e il cuore si placa comunicandogli una gioia profonda quando trova un’altra scheggia di pietra disposta a incastrarsi agevolmente, come se fosse stata appena estratta, dentro la cavità che fino a quel momento sembrava appartenere a un disegno fantasioso ma coerente. La gioia è così grande da estinguere la paura di non arrivare mai alla fine. Quando osserva il paesaggio dalla pianura al cielo, se ne riempie l’animo, eppure gli sembra che il mondo sia sospeso, in attesa di essere compiuto. Giunge la vecchiaia e gli restano pochi giorni di vita, ma ha ricomposto il picco in tutte le sue parti; egli è l’unico a sapere che dentro la cima della montagna brilla una piccola sfera perfetta».
Ascoltato il racconto, io continuai a tacere, mentre Velly si alzava, attratto dalla tela non finita. Prese un piccolo pennello e cominciò a dipingere intorno agli zigomi dell’autoritratto, ignorandomi. Guardai nello specchio che egli guardava. I suoi occhi erano impietriti.